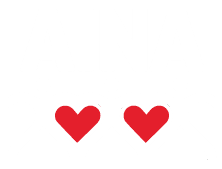Sara - Luglio 2018

Diario di viaggio
14 luglio
Oggi all’Aina Home Children è un giorno di svago.
Il sabato si frequenta la scuola solo al mattino e i bambini e i ragazzi hanno più tempo libero. I momenti di gioco si alternano alle responsabilità: si fa la doccia, il bucato e le camere vengono fatte arieggiare. I più piccolini ne sono esenti, ma i più grandi (dagli 8 in su) devono dare una mano. I vestiti vengono stesi tutti insieme all’aperto ed ogni capo ha un numero (che indica l’età, ad esempio 7 anni) o il nome del bambino o del ragazzo, scritto all’interno con un pennarello indelebile. I vestiti vengono raccolti e portati in una grande stanza e i ragazzi stessi li smistano: nursery, boys, girls. Do loro una mano e quando raccogliamo le mutande sono grosse risate. È un momento per fare conoscenza.
Quanti anni hai? In Italia c’è il nome Wendy? Milde? Kanana?
Cosa ti piace mangiare? Ti piace la pizza? E i fagioli? Sei stata in Canada? E in Giappone?
Tu sembri indiana con questi capelli!
I capelli lunghi sono incredibili da guardare e da toccare per le ragazze, che portano i capelli rasati per una questione prettamente igienica. Vengo assalita da decine di ragazzine che si improvvisano acconciatrici, litigano tra di loro per chi deve avere l’onore di farmi una treccia. Tutto ciò che sta in testa crea stupore: forcine, elastici, pinze. E gli orecchini sono una chicca che alcune ragazze devono ancora assaporare.
I maschietti invece mi accompagnano a fare un giro alla fattoria. Conoscono l’albero genealogico di tutti gli animali presenti.
Questo maiale è la mamma di questo, di questo e di questo. Poi ci sono i vitellini, Come to see, take a picture! Ai bovini sono stati dati nomi di persone conosciute dai bambini, tra cui la coordinatrice del villaggio, una ragazza romana di 25 anni che i ragazzi amano e rispettano come un capofamiglia.
È importante che io salga su un gruzzolo di terra per vedere l’uovo appena fatto dalla gallina.
E poi via a guardare dalle finestrelle il mangime, gli attrezzi da lavoro e il bue dei vicini del villaggio, oltre la rete.
Poi si corre tutti verso il cancello, qualcuno ha portato dei lecca lecca. Urla di festa, profumo di fragola e lingue rosse.
La giornata è trascorsa così, tra doveri e piaceri, iniziata sbucciando piselli sotto un cielo grigio e conclusa con un caldo sole, tra i sorrisi e i canti dei 100 bambini e ragazzi che vivono alla Meru Home Children, poiché orfani o figli di genitori troppo poveri che, per assicurare loro una vita e delle cure migliori, hanno fatto una scelta difficile, per amore. Lo stesso amore che loro sanno donare.
15 luglio
Ogni 15 del mese al villaggio di Aina si festeggiano tutti i bambini nati nel mese corrente. Una modalità che permette di fare una festa per tutti: 100 feste di compleanno non possono essere sostenute. Per cui si sceglie un menu diverso dal solito: stasera patate al forno e pescegatto fritto. Da bere succo di ananas: l’ananas viene fatta bollire in modo da estrarre l’intero succo. E una grande torta. I bambini sono euforici, urlano e cantano. I visi neri si riempiono di zucchero a velo e le mani sono appiccicose. Anche noi ci lasciamo trasportare da questo momento di grande festa, battendo le mani sui tavoli e sulle panche, dando vita a piccole coreografie. I festeggiati si riuniscono davanti alla torta e tutti insieme ne danno il primo taglio. Non ci sono regali, non ci sono palloncini. L’attenzione non è sul singolo, ma sempre sulla comunità, anche in questo caso, anche nel giorno, anzi, nel mese, del proprio compleanno.
17 luglio
Trascorrere il tempo qui a Nchiru vuol dire svegliarsi la mattina appena sorge il sole poiché non ci sono le tapparelle alle finestre, salutare gli agricoltori che armati di stivali e attrezzi si muovono come degli omini Lego; attendere che i tre piccoli del villaggio, Victor, Christine ed Angel si accorgano che siamo nei paraggi per vederli correre verso di noi, ridendo a crepapelle; aspettare l’ora della merenda così da dare il cinque a tutti i bambini e ragazzi che si recano in sala mensa, con le loro uniformi, talvolta rattoppate; respirare aria fresca, quella che ti è mancata per gran parte dell’anno lavorativo e dei weekend; sai che durante la giornata ti toccherà almeno un ban, un tiro a canestro, un abbraccio (dato e ricevuto), un sorrisone bianchissimo, un animale poco gradevole che occuperà i tuoi spazi, una doccia che in realtà è una battaglia con l’acqua che non c’è o con lo scarico tappato; una frase illusoria di Maria Rosa (corri, credo di aver visto un elefante! [pura allucinazione, nata dal fatto che ci è stato detto che dalla foresta di fronte spesso escano degli elefanti, ma sappiamo che non avremo questa fortuna) e da una buona ricetta creata con pochi ingredienti da Federica. È avere un libro sul comodino, comprato appositamente per questo viaggio, mai letto ancora. Doveva essere un compagno, ma quelli che ti sono accanto vanno benissimo così. Dopo una giornata piena, che meriterebbe il suo diario quotidiano, mi ritrovo un po’ malinconica, adesso che mi sono sistemata nel mio letto simil baldacchino con la tenda per le zanzare, la quale sembra darti un grande abbraccio. Il pensiero fa un salto in avanti, come un grillo deciso, pensando al dopo, al ritorno. Inutile descrivere il varco che ti si apre nel petto. Ma il grillo si trasforma subito in un gambero: fa un passo indietro e ti riporta alla realtà, quella africana, questa.
Oggi siamo state al mercato di Meru e abbiamo espresso il desiderio di tornare al villaggio in moto. A Meru molti ragazzi hanno una moto che usano come taxi, è il loro lavoro. Le moto piene di bandierine e con la radio a tutto volume. Saliamo in tre, qui si usa così: il motociclista, un ragazzo fidato, io e Maria Rosa. Sulla destra c’è un tramonto mozzafiato, la moto corre ed io e Maria Rosa ridiamo a non finire. E mentre saltiamo sulla sella a causa delle buche della strada in terra battuta, mi volto e dico “Mari, siamo in Africa!”.
Credo sia questo quello che conti, aver utilizzato il verbo al presente. E “presente”, come ci è stato insegnato, vuol dire anche regalo.
19 luglio
Dopo quasi una settimana all’Aina Children Home, ci sentiamo a casa nostra. Ci siamo ben ambientate e ormai seguiamo anche noi la quotidianità. Stamattina abbiamo finalmente completato lo store. Che uno se lo dice in Italia immagina i grandi magazzini, invece qui si tratta di una sorta di stanzino rustico, col tetto in lamiera, e alcuni armadi all’interno dei quali abbiamo suddiviso tutto l’abbigliamento arrivato dall’Italia. I bambini e i ragazzi di Aina sono curiosi, si intrufolano dentro lo stanzino, ma il “non si tocca” è internazionale, quindi permettiamo loro di tagliarci solo un po’ di scotch e di sistemare qualche scatola vuota. Dei vestiti smistati alcuni molto carini al profumo di Dixan; altri, in condizioni pietose, roba con buchi e alquanto usurata, tra cui un reggiseno che sembrava preso a morsi da un cane. Questo mi disgusta, sinceramente. Come se i bambini, poiché “poveri che non hanno da mangiare”, dovessero indossare la fezza. Il tutto viene mandato giù con un sospiro, perché ciò che conta è che adesso finalmente si può sostituire gran parte dei vestiti.
Ieri siamo stati al grande mercato di Meru e ci siamo perse tra i colori della frutta, l’odore di soffritto e il vociare. Tra il traffico e le bancarelle sbucano pecore e galline.
Inoltre, ieri, dopo aver colorato e disegnato con la nursery, una scena che mi ha toccato: i bambini messi in fila, pronti col bicchierone d’acqua a buttare giù con un sorso i farmaci. Prince apre grande la bocca per far vedere alla house-mother di averle realmente prese.
Un pensiero stupido, probabilmente, perché quei farmaci permettono loro le cure necessarie, e la vita. Credo che mi abbia commosso quella diligenza, il rispetto della fila, la piccola Helene che aiutava a sistemare i portapillole, una routine quotidiana che però mi tocca e mi commuove mettendolo per iscritto.
Su alcuni letti dei dormitori ci sono dei pupazzi, sgualciti, ma teneri. Il pupazzo in psicologia viene descritto come l’oggetto transizionale che sostituisce in qualche modo la madre, prima di distaccarsene completamente. Qui ascolto delle storie di sofferenza, di madri e padri che non ci sono più; a volte ci sono degli zii, una nonna; a volte non c’è nessuno.
I bambini africani crescono in fretta, non potrebbe essere altrimenti. Gli educatori svolgono un lavoro fantastico e preparano grandi e piccoli alla vita, perché Aina un giorno finirà per loro, e dovranno essere forti e in gamba, anche se il villaggio resterà per sempre una grande famiglia per loro, come per Mouthuma, 25enne, studente universitario e che in questi giorni passa da qui, a trascorrere un po’ di tempo al villaggio. E noi siamo ben lieti della sua presenza, soprattutto quando lo chiamiamo al cellulare per venirci a soccorrere dai pipistrelli che entrano in casa, ahìnoi, troppo spesso.
L’affetto cresce ogni giorno sempre di più e questo ci mette in crisi, perché arriverà il momento del distacco e non sarà facile.
E mentre bacio Wendy e lei ride, come se le facessi il solletico, rifletto sul fatto che questi bambini non crescono col contatto materno: coccole, grattini, abbracci non fanno parte del menu quotidiano, perlomeno, non come quello che avrebbe dato una madre. Ciononostante, i bambini qui sono al sicuro, vengono nutriti e curati. Il villaggio di Aina è un faro nel buio.
22 luglio
Il sabato a Meru: la mattina un salto in città, dove mezzi di ogni tipo e con quante più persone possibili sopra continuano a sorprenderci, il pomeriggio lo trascorriamo con i bambini che provano in tutti i modi ad insegnarmi un canto tradizionale in swahili e, dopo tante grosse grasse risate, ce la faccio!
Prepariamo inoltre un dolce alla signora Rose, nostra vicina di casa la quale, scoprendo che Maria Rosa porta il suo stesso nome, le ha donato un piccolo ma prezioso regalo. Ormai al villaggio ci conoscono e veniamo ben accolte per la strada sterrata e con la terra rossa. William, il guardiano notturno, come ogni sera ci accompagna fino alla porta di casa, armato di torcia e lancia. Questa cosa ci fa sempre molto ridere. Ancor più ridere quando, per andare a sbirciare i maialini che dormono, io e Federica cadiamo direttamente in una fossa. Tiriamo su le lenzuola e la zanzariera e.. lala salama!
23 luglio
Vyette, Lilian, Ann, Kesline, Polline, Yvonne, Nora, Linda, Glory, Brian, Monene, Clifford, Kiroku, Manuel, Armstrong, Nicholas, Prince, Dennys, Moses, Victor, Kanana, Christine, Angel, Mobeen, Princess, Price, Wendy, Helene, Peter, Joy, Sharon, Polly, Joshua, Betty, Freeda, Rose, Faith… solo alcuni dei 130 bambini del villaggio di Aina. Se si potesse contare quante teste abbiamo accarezzato, quante mani abbiamo stretto, quanti abbracci abbiamo donato, quanti baci dolcemente dato, in quanti sorrisi la nostra bocca si è allargata, quanti occhi abbiamo incrociato, quanto abbiamo corso e rincorso, saltato, quante altalene spinte, e quanti vola-vola volato, quanti vestiti abbiamo piegato, quanta terra rossa abbiamo sollevato, quanta aria fresca abbiamo respirato, quanti Ciao e Jambo con la mano abbiamo pronunciato… tutto questo ha un valore inestimabile. Ho realizzato il sogno della mia vita venendo qui, sono venuta “a casa loro”, e ho trovato sorrisi grandi quanto la loro povertà, e una capacità di resilienza che un occidentale dopo tre giorni sarebbe impazzito. I loro movimenti, il modo di versare il the mischiato con il latte, di portare i sacchi di patate, di ballare a ritmo, di camminare con i bambini dietro la schiena, di sorridere, sempre, di staccare le verdure dalla terra, di acconciarsi i capelli, di indossare abiti poco abbinati e di stagioni diverse restando pur sempre affascinanti, di camminare scarpe più grandi. Questa solo una piccola fetta di tutto ciò in cui ci siamo calate in questi giorni, con tutte le scarpe e con tutto il cuore. Ringraziare sempre, ad ogni complimento o melanzana ricevuta.
Noi, unici bianchi in questo villaggio di neri.
24 luglio
Nessuno ci ha detto che sarebbe stato straziante.
Nessuno ci ha detto che avremmo versato fiumi di lacrime.
I più piccoli non lo avevano ancora capito, finché stasera non è stato loro spiegato in swahili.
Quando, dopo aver compreso, vengono vicino ad accarrezzarmi il viso e mi passano le dita sul naso, sulle guance, sui nei, mi sento morire.
Abbiamo realizzato una ghirlanda di angeli e la abbiamo appesa nel dormitorio.
I bambini e i ragazzi la guardavano attentamente, come qualcosa di straordinario.
Un batticinque dalla culla.
Wendy mi dice qualcosa di dolce, lo capisco dal tono della voce, ma non capisco il swahili.
Change your ticket.
Why you go away?
Come again!
Se chiudo gli occhi, vedo un rullino di immagini meravigliose.
Nell’ultimo vola vola, abbraccio e respiro Kanana, lei, uno dei primi sorrisi che mi ha subito colpito.
Asante sana
28 luglio
Il viaggio dall’Italia al Kenya (e viceversa) è interminabile, occorrono più di 24 ore. All’andata i bagagli erano molto pesanti, abbiamo cercato di portare un po’ di tutto al villaggio Aina. Al ritorno, zaini e valigia sono, in confronto a prima, vuoti. Ripenso alla Sara della partenza e alla Sara del ritorno. Più volte in questi giorni ci siamo chieste il perché di questo viaggio, con la consapevolezza che, decidendo di venire in Kenya, avremmo potuto scegliere di farci una super vacanza sulle spiagge più bianche di Watamu e delle altre isole. Ho avuto modo di vivere l’Africa vera per due settimane e l’Africa turistica per due giorni. A Malindi molti parlano italiano. Hanno costruito un casinò e Briatore ha un grosso locale. I bar e i ristoranti portano spesso nomi italiani. È come se a volte si spersonalizzassero per accogliere i nostri vizi. Elius, la nostra guida, l’ha capito fin da subito che non eravamo delle turiste. L’ha capito quando gli abbiamo detto che non c’era bisogno che ci aprisse la portiera della macchina o che ci portasse i bagagli a tutti i costi. Sulla lunga strada che porta al parco nazionale dello Tsavo, ho visto la povertà. Famiglie che vivono in capanne sotto il sole cocente, le mamme che tengono in braccio i piccoli. Dalle maglie si intravede che non portano il reggiseno. I bambini scalzi, coi piedi neri sporchi del bianco della polvere. I muzungu (in swahili, uomo bianco) portano le caramelle. I bambini sanno a che ora le jeep escono dal parco, per cui attendono sulla strada, stendendo le braccia. È un gesto questo che non mi fa stare bene, non del tutto. L’uomo bianco è quello che porta le caramelle. Per tale motivo, ripensare alle due settimane trascorse all’Aina, mi rincuora.
Sulla costa, a Malindi c’è una grande comunità musulmana e alle 5 di mattina veniamo svegliate dal richiamo alla preghiera della moschea di fronte. Penso a come ci vedono, noi italiani che andiamo lì, coi costumi e i cappelli e la prima cosa che chiediamo in un paese straniero è il caffè e la pizza. A volte non abbiamo il desiderio di conoscere realmente i luoghi che ci ospitano. Io ci ho provato, ad esempio con un signore che lavorava di sera, col buio pesto, al laboratorio del legno; mostro lui i lavori di mio padre e alla fine, ben lieto della conversazione, mi regala un mestolo in legno.
I bambini e i ragazzi di Aina sono sempre lì, tra un pensiero e un altro. Wendy, Peter, Kanana… In genere si accoccolavano sulla mia pancia morbida. Penso a tutto l’affetto che mi hanno dato e a quello che ho provato a dare io a loro.
Penso a quando li rivedrò, perché un giorno vorrei rivederli, e trovarli cresciuti, con l’inglese fluido che con i più piccoli si fermava al What’s your name o, nel caso di Peter, ad un Yes lanciato a random, scollegato da ogni discorso, che mi faceva sempre morire dal ridere. Penso che i viaggi, se vissuti nel modo giusto, facciano bene all’anima e al cuore, come frutta e verdura. Penso che non avere la curiosità di conoscere gli altri popoli, è come non voler conoscere noi stessi, quella parte straniera che vive in ognuno di noi. Penso alla comfort zone, che ti garantisce il quieto vivere ma non l’ebrezza del nuovo e di guardare il mondo con gli occhi del bambino, che tutto scrutano. Credo che nulla avvenga per caso e che il “Un giorno andrò in Africa” si sia compiuto nel momento esatto in cui doveva compiersi. Né prima, né dopo.
Sara